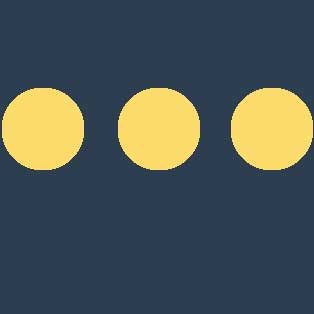Con la sentenza qui presa in esame la Suprema Corte si è pronunciata su una contestazione avente ad oggetto la fattispecie di Costrizione o induzione al matrimonio, prevista e punita dall’art. 558-bis c.p., recentemente introdotta nel codice penale dalla legge n. 69 del 2019, il cd. Codice Rosso.
Riportiamo la prima parte del commento di Giordana Pepè su Sistema Penale.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi – e a ribadire le posizioni già espresse in numerose altre occasioni – in materia di reati culturalmente motivati. Oltre all’efficace sintesi degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità su questo spinoso tema, a rendere interessante la decisione è la peculiarità del caso con cui la Suprema Corte si è confrontata, espressione di un fenomeno sommerso e ben poche volte giunto al suo esame, che fornisce anche l’occasione per soffermarsi su una norma di recente introduzione nel codice penale (l’art. 558-bis c.p., costrizione o induzione al matrimonio). Si trattava, invero, della “cessione” in matrimonio di una ragazza di etnia Rom minore di sedici anni, a fronte del c.d. “prezzo della sposa”.
I fatti
Imputato era il padre della giovane, che – senza il consenso di lei – l’aveva promessa e data in sposa ad un uomo, ricevendo in cambio un beneficio economico da parte del “patriarca” della famiglia cui apparteneva lo sposo. In primo grado è stato ritenuto responsabile del reato di riduzione in schiavitù (ex art. 600, comma 1, prima parte c.p.), aggravato per essere la vittima minore degli anni sedici e l’autore del reato il suo ascendente (ex art. 602-ter, commi 5 e 6 c.p.); sentenza confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze, che ha tuttavia ritenuto applicabili le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza sulle predette aggravanti ed una conseguente rimodulazione della pena), in ragione “della particolare condizione subculturale” in cui versava il soggetto.
Contro la pronuncia di seconde cure hanno fatto ricorso in Cassazione sia l’imputato che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultimo in particolare ha contestato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la valutazione sulla “condizione subculturale” dell’imputato risultava confliggente con le risultanze processuali – attestanti al contrario un suo risalente e stabile inserimento in Italia –, ed era in ogni caso inidonea a giustificare la diminuzione di pena. Tale censura è stata ritenuta inammissibile dai Giudici di ultima istanza, in quanto attinente al merito della decisione e non essendo la motivazione sul punto manifestamente illogica. La sentenza è stata invece annullata con rinvio limitatamente al solo trattamento sanzionatorio.
In due dei quattro motivi di ricorso proposti dalla difesa dell’imputato, invece, si è fatto leva soprattutto sulla sua diversa cultura e sul peculiare significato rivestito dalle tradizioni legate al matrimonio in uso presso il popolo Rom.
Da un lato, infatti, si è affermato che l’uomo non aveva agito aderendo ad una mera “tradizione” della comunità Rom cui apparteneva, bensì in modo conforme ad un vero e proprio “ordinamento giuridico” vigente in essa, nel quale la cessione di una sposa a fronte di un prezzo corrisponderebbe ad un istituto giuridico consolidato, avente funzione di “risarcire” la famiglia della sposa per la perdita di un proprio membro e non certo di compravendere un essere umano. Per tali ragioni, il ricorrente lamentava l’errata valutazione sulla configurabilità del reato contestato, che la Corte di secondo grado aveva ritenuto sussistente individuando lo sfruttamento della ragazza proprio nel vantaggio patrimoniale conseguito dal padre di quest’ultima, così ignorandone il predetto significato culturale (e senza peraltro specificare in quale delle due forme previste dall’art. 600, comma 1 c.p. si era realizzato il reato).
Dall’altro lato, si è sostenuta l’assenza dell’elemento psicologico del reato, data la mancata consapevolezza, da parte dell’imputato, del processo di “reificazione” cui stava sottoponendo la figlia, proprio alla luce delle sue influenze culturali e dell’ordinamento giuridico di riferimento, in conformità del quale era convinto di agire.
Su tali questioni si è incentrata principalmente la sentenza della Suprema Corte, che ha rigettato entrambe con un approfondito percorso argomentativo.
Dapprima, i Giudici di legittimità si sono soffermati sull’asserita omessa qualificazione giuridica dei fatti, ritenendola infondata in quanto la Corte d’Appello aveva considerato l’imputato responsabile, come descritto nel capo d’imputazione, della fattispecie sanzionata dalla prima parte dell’art. 600, comma 1 c.p.: “chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”. Invero, si è ravvisato l’esercizio, sulla minore, di un dominio equivalente a quello esercitabile su una cosa in virtù di un diritto dominicale.
Peraltro, valorizzando la lettera della legge (che richiede la mera “corrispondenza” tra i poteri di fatto esercitati e quelli del diritto di proprietà), la Corte di ultima istanza ne ha ribadito un’interpretazione atta ad includere “non solo la condizione di schiavitù di diritto, ma altresì quelle situazioni nelle quali di fatto venga esercitata su di un altro essere umano una signoria così pervasiva da risultare equivalente nel suo contenuto alle forme di manifestazione del diritto di proprietà”. Un processo di reificazione della persona, insomma, che ne comporta ex se lo sfruttamento e che ben poteva essere individuato, secondo i Giudici, nella percezione di un guadagno per la cessione della ragazza.
Questa argomentazione, come accennato, risulta in linea con l’interpretazione consolidata data dalla Cassazione più recente alla norma in questione: in particolare, possono menzionarsi due casi simili a quello in commento, che sono stati oggetto di sentenze rispettivamente nel maggio 2016 e nel marzo 2019.
Si era trattato, nel primo, di una minorenne kosovara condotta in un campo nomadi in Italia da una coppia, con la promessa di corrispondere alla sua famiglia 20.000 euro (in acconto dei quali erano stati versati 1.000 euro), per unirla in matrimonio con il loro figlio, anch’egli minorenne, nonostante il dissenso di lei. La giovane, tra l’altro, era stata costretta a svolgere prestazioni domestiche e sessuali nei confronti del marito, isolata, senza passaporto, in un nucleo di persone che non riconosceva come sua famiglia.
La Corte aveva ritenuto sussistente il reato di riduzione in schiavitù, affermando che “la riduzione della persona offesa ad oggetto di scambio commerciale, mediante la sottoposizione della stessa ad un atto di compravendita, integra di per sé una situazione di sfruttamento rilevante ai fini della configurabilità dei reati in esame, in quanto tale da rendere la vittima una res sulla quale esercitare diritti patrimoniali e da cui trarre utilità economiche”. Principio confermato nella successiva pronuncia, relativa ad una vicenda parzialmente diversa, in quanto tre uomini Rom avevano “acquistato” come spose tre donne (di cui una minorenne) provenienti dalla Romania, trattando e accordandosi con un terzo estraneo alle loro famiglie.
Più interessanti – per quanto anch’esse in linea, come si dirà, con l’orientamento ormai granitico della Suprema Corte sul punto specifico – risultano le considerazioni svolte sul tema delle motivazioni culturali. Dopo aver accuratamente definito i c.d. “reati culturali” come la traduzione in termini giuridici del “conflitto che si determina tra ordinamenti di tipo consuetudinario tradizionale e ordinamenti di tipo statuale”, in presenza di un comportamento considerato illecito dall’ordinamento giuridico (espressione della cultura dominante) del luogo in cui viene tenuto, ma normale, approvato o addirittura incoraggiato dal gruppo culturale minoritario cui appartiene il soggetto che lo pone in essere, in quanto “conforme alle consuetudini ed alle tradizioni religiose o sociali costituenti la cifra identitaria del gruppo medesimo”, gli Ermellini hanno ripercorso puntualmente i loro orientamenti in materia.
In particolare, hanno rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia espresso posizioni solo apparentemente eterogenee nell’attribuire o meno rilevanza ai fattori culturali, e nell’ancorarla eventualmente ai diversi profili della struttura del reato (tipicità ed offensività, antigiuridicità, colpevolezza, o commisurazione della pena), anche a seconda dei casi concreti e delle doglianze dei ricorrenti. Invero, l’evoluzione sul tema ha portato a riconoscere “che dal regime di pluralismo confessionale e culturale delineato dalla nostra Costituzione agli artt. 2 e 8”, nonché da numerose fonti internazionali, discende un “diritto del singolo alla tutela della propria identità culturale e religiosa”, il quale però non può avere prevalenza assoluta e indiscriminata e deve essere bilanciato con gli altri diritti e interessi in gioco.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha sempre ed omogeneamente “escluso la configurabilità di una ‘scriminante culturale’ in tutti quei casi in cui l’esercizio del diritto dell’agente a rimanere fedele alle regole sociali del proprio gruppo identitario di riferimento si traduce nella negazione dei beni e dei diritti fondamentali configurati dall’ordinamento costituzionale presidiati dalle norme penali violate”. Necessità sancita, del resto, dalle stesse fonti internazionali che pure riconoscono il “diritto alla cultura”, nonché, con specifico riferimento alle violenze contro le donne, dall’art. 42 della Convenzione di Istanbul.
Calando questa chiara (ri)affermazione di principio nel caso concretamente al suo esame, la Suprema Corte ha affermato l’impossibilità di attribuire, su un piano oggettivo, alcuna valenza scriminante alle regole ed alle consuetudini della cultura Rom, posto che il soggetto agente ha leso un bene giuridico di rango costituzionale, appartenente al nucleo irrinunciabile dei diritti fondamentali della persona umana: la libertà individuale tutelata dall’art. 600 c.p., intesa come status libertatis (“ossia, non una forma particolare di manifestazione della libertà individuale, bensì il complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato e la cui negazione comporta l’annientamento della stessa personalità dell’individuo”).
L’unico varco lasciato aperto al possibile riconoscimento di motivazioni culturali anche in presenza di condotte lesive di beni fondamentali è stato individuato in “altri elementi strutturali del reato” (che non incidano sull’oggettiva rilevanza penale della condotta), o nella commisurazione del trattamento sanzionatorio (sia entro la cornice edittale, sia tramite circostanze attenuanti): da qui il corretto operare del Giudice di secondo grado che aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
Anche in tali statuizioni, la Corte di legittimità si è dimostrata coerente con le due precedenti sentenze già citate.
Nel primo caso (deciso nel 2016), a giudizio delle Corti di merito non erano ravvisabili né uno stato di soggezione continuativa, né uno sfruttamento sessuale o lavorativo (bensì “semplici mansioni domestiche”), mentre la corresponsione di una somma di denaro alla famiglia d’origine della giovane trovava le sue radici nella particolare cultura degli agenti (in cui i matrimoni combinati erano d’uso), e pertanto non poteva integrare il reato di riduzione in schiavitù. Come già anticipato, in ultima istanza si è invece riconosciuto il reato di cui all’art. 600 c.p., giudicando sufficiente a integrarlo la compravendita della ragazza, con riferimento alla quale si è affermato che “le motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente non incidono sulla rilevanza penale della condotta, nelle sue oggettive connotazioni, rispetto alle previsioni incriminatrici in tema di riduzione in schiavitù”.
Quanto alla sentenza del 2019, questa ha confermato la sussistenza del dolo di riduzione in schiavitù, data l’impossibilità “di riconoscere valenza scriminante o di esclusione della punibilità alle peculiarità culturali ed alle tradizioni del popolo Rom, seppure certamente condivise dagli imputati”, e valorizzando il fatto che in quel caso non si trattava neppure di un vero e proprio “matrimonio per compera” combinato tra famiglie secondo la cultura Rom.
Decisamente più sintetiche sono state, invece, nella pronuncia del 2021 in esame, le motivazioni in punto di elemento soggettivo. La Corte Suprema, infatti, si è limitata a rilevare che le decisioni di merito, pur senza negare che l’imputato avesse agito in aderenza a modelli comportamentali quantomeno tollerati nella sua cultura di riferimento, facevano emergere altresì la sua piena consapevolezza dell’illiceità, secondo l’ordinamento italiano, della condotta realizzata. Il che si poteva ricavare sia dalla risalente presenza dell’uomo nel nostro territorio, sia dalle conversazioni telefoniche intercettate con il fratello, che mostravano “il tentativo di concordare una versione di ‘comodo’ per gli inquirenti”. Pertanto, l’unico ambito in cui poteva ammettersi qualche riconoscimento della cultura dell’imputato era quello, correttamente individuato dalla Corte territoriale, delle circostanze attenuanti generiche.